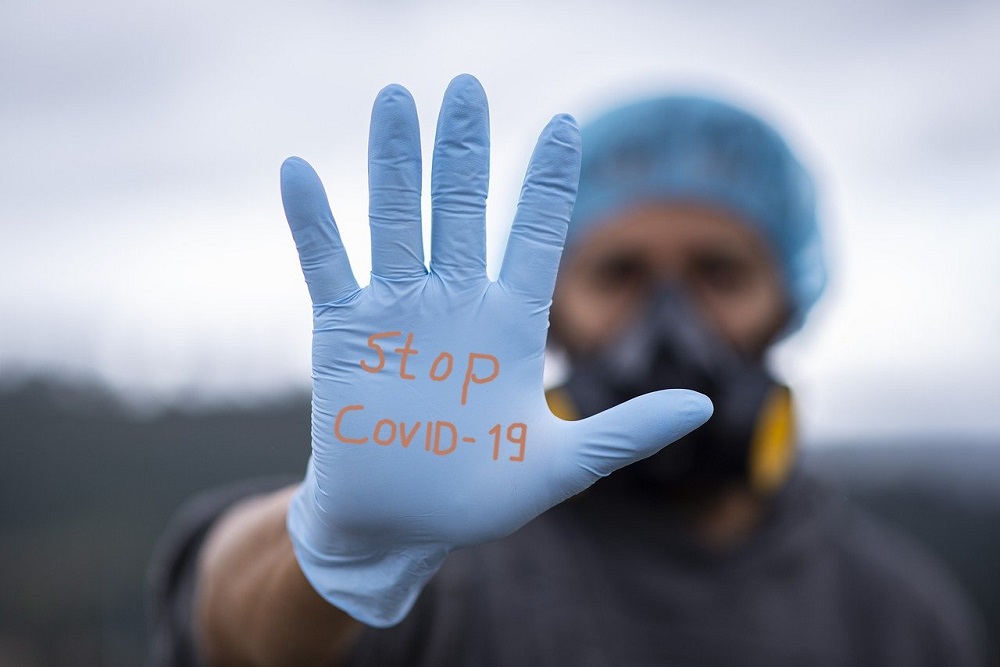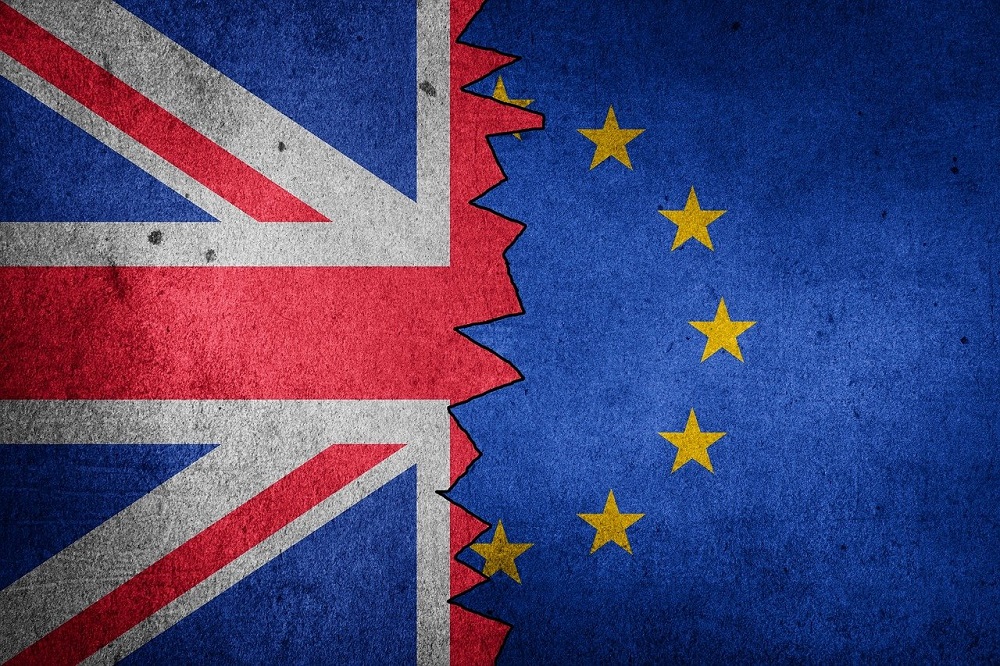
Presi dalle inevitabili usanze natalizie e dalle restrizioni da Covid che le hanno rese un po’ più originali del solito non ci siamo quasi accorti dell’unica cosa importante di questo fine d’anno: raggiunto in “zona Cesarini” un accordo, dal 1 gennaio la Gran Bretagna non farà più parte dell’Unione Europea. Trovare un’intesa in tempo utile sembrava ormai impossibile, e il no deal (cioè l’uscita senza accordo) pareva inevitabile. Poi, dopo il volo improvviso di Johnson a Bruxelles, il barometro ha volto al bello e la convenzione che consentirà di mantenere un’area di libero scambio tra tutti i 27 paesi è stato firmato. La domanda è: come mai? E quella successiva: chi ci ha guadagnato (e chi ci rimette)?
Accordo necessario
La prima risposta è relativamente semplice: un no deal avrebbe messo in forti difficoltà Johnson, soprattutto nei tempi brevi. Troppe circostanze giocavano contro di lui: il timore di un’improvvisa impennata dei prezzi di alcuni generi di prima necessità importati dal continente (erano già cominciati gli accaparramenti, migliaia di autocarri sostavano a Calais per raggiungere l’Inghilterra prima che i dazi si facessero sentire), l’allarme della finanza che continuava a traslocare dalla City di Londra in cerca di siti più accoglienti, le nuove fibrillazioni indipendentiste della Scozia, la stessa elezione di Biden che faceva venir meno l’asse preferenziale (più presunto che vero) con Trump. In tali circostanze il volo di Johnson tra le braccia di Ursula von der Leyen sembrava quasi una disperata richiesta di aiuto.
Tuttavia la risposta alla seconda domanda è in netta contraddizione con la prima perchè, almeno in apparenza, chi esce vincente dal compromesso è proprio Johnson, il quale, non a caso, ha subito lanciato messaggi trionfalistici.
Le questioni ancora sul tappeto dopo un anno di trattative erano infatti tre: la frontiera irlandese, i diritti di pesca nel mare del nord e le regole del libero scambio per evitare che di fatto gli operatori britannici potessero fruire di un vantaggio non concorrenziale (come un fisco più favorevole, eventuali aiuti di Stato o normative meno onerose in campo ambientale, ecc.). Di questi problemi il più importante è il terzo (non certo la pesca che interessa una percentuale trascurabile degli scambi) e la soluzione trovata che esclude la competenza giurisdizionale dell’UE rimettendo eventuali (inevitabili) controversie a un indefinito “arbitrato internazionale” sembra accogliere le richieste britanniche. Johnson sembra quindi avere ottenuto quanto voleva: il mantenimento di una zona di libero scambio (che conviene al Regno Unito, importatore netto) senza regole vincolanti per gli imprenditori britannici che non siano passate da Westminster. C’è di più: un accordo così favorevole mette in crisi il progetto secessionista degli indipendentisti scozzesi per la difficoltà di dimostrare la convenienza di tornare a far parte dell’Unione. Perchè dunque tanta improvvisa accondiscendenza da parte della von der Leyen (e, dietro di lei, dell’asse Macron – Merkel) nei confronti del governo di Londra?
L’ovvia risposta che un’intesa qualsivoglia conviene a tutti i partner non spiega perchè se ciò è vero non si sia chiusa l’intesa molto prima. Resta da capire se qualcosa di nuovo è intervenuto e in tal caso di che si tratti.
Europa a due velocità
Forse la vera risposta arriverà nel corso del prossimo anno e consistere nel rilancio di un’Europa a due velocità: da una parte una zona di libero scambio molto ampia (che potrebbe comprendere anche paesi che oggi non fanno parte dell’Unione come la Norvegia, la Svizzera, l’Ucraina, la Serbia, l’Albania) con istituzioni in grado di regolarne gli scambi commerciali, dall’altra una più solida confederazione politica e militare, dotata di una moneta comune e di una autentica costituzione fondata sul riconoscimento delle regole dello stato di diritto (tale quindi da spingere paesi esplicitamente illiberali e intolleranti come la Polonia e l’Ungheria a decidere definitivamente da che parte stare). Se di questo si tratta si capisce meglio perchè anche un accordo apparentemente vantaggioso per il Regno Unito può essere accettato dall’Unione Europea. Tanto più se – come ci si augura – l’amministrazione Biden rilancerà il multilateralismo democratico non soltanto rafforzando la NATO ma anche costruendo nuovi rapporti di alleanza con i paesi che in Occidente e in Oriente si riconoscono nei principi dello stato liberale e che non sono soltanto quelli legati da tradizioni di origine anglosassone (come nel caso di Canadà, Australia, Nuova Zelanda) ma anche altri che hanno ormai da molto tempo inserito quei valori nelle proprie culture politiche e sociali.
Franco Chiarenza
28 dicembre 2020