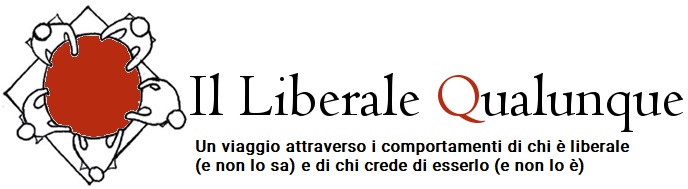Che nell’opinione pubblica emergano posizioni diverse nei confronti del blitz di Putin che di fatto sta annettendo alla Russia una parte dell’Ucraina non stupisce e rientra in una sana dialettica democratica. Anche perchè, come sempre in politica, non mancano argomenti validi per i favorevoli quanto per i contrari. Stupisce di più trovare tra coloro che difendono l’operato della Russia alcuni amici liberali. Soltanto per questa ragione ritengo necessario fare un po’ di chiarezza nella mia qualità di componente della tribù dei “liberali qualunque”.
- La guerra in corso si svolge su due piani distinti che si intersecano ma non vanno confusi: c’è un conflitto tra stati in cui una grande potenza sta cercando di sopraffare e di annettersi un paese confinante e che si esprime attraverso un duro scontro militare, e c’è una contrapposizione ideologica tra una concezione autoritaria dello Stato e quella opposta articolata in un sistema liberal-democratico. Non sempre i due piani coincidono: ci sono fautori del populismo autoritario anche nell’Unione Europea (Polonia, Ungheria), oggi silenti ma pronti a riemergere, e ci sono (per fortuna) convinti democratici anche in Russia (repressi con durezza dal regime). I liberali non possono nelle loro valutazioni non tenere conto che lo scontro ideologico è più importante di quello tra forze armate nazionali. Come d’altronde avvenne anche nella seconda guerra mondiale.
- Le rivendicazioni storiche di Putin non rappresentano quindi il punto della questione; inutile addentrarsi in una discussione sul patriarcato di Kiev, sulla linea di confine tra russofoni e autoctoni (sostanzialmente ruteni), sulle infinite modifiche territoriali e etniche prodotte da secoli turbolenti caratterizzati da antiche ambizioni egemoniche della Russia ma anche dai tentativi ricorrenti di molti popoli slavi di staccarsi dalla “Grande Madre”. Se dovessimo rifarci alla storia apriremmo un contenzioso infinito che coinvolgerebbe anche il nostro Paese dove esistono minoranze di lingua tedesca (Alto Adige) e che è stato privato di territori certamente in prevalenza italofoni come l’Istria del Litorale, alcune città della Dalmazia, e, cedute alla Francia per ragioni e modalità diverse, la città di Nizza e la stessa Corsica (dove la lingua ufficiale si rifaceva alla lunga dominazione dei pisani e dei genovesi.). E’ tipico delle dittature appoggiare le proprie mire espansioniste e egemoniche a rivendicazioni etniche superate dalla storia (e infatti hanno rappresentato per Hitler e Mussolini il pretesto per scatenare la seconda guerra mondiale).
- Per queste ragioni che riguardano quasi tutti i paesi europei vennero sottoscritti anche dall’Unione Sovietica nel 1975 a Helsinki degli accordi che stabilivano l’inviolabilità dei confini stabiliti dopo la seconda guerra mondiale, giusti o sbagliati che fossero, e che i diritti delle minoranze etniche e linguistiche sarebbero stati tutelati mediante forme di autonomia da concordare (come noi abbiamo fatto per l’Alto Adige). Putin non lo nega ma sostiene che tali accordi sono stati violati dalla Nato in occasione del conflitto in Bosnia e col riconoscimento del Kosovo sottratto nel 2008 alla sovranità serba. Il che è vero ma senza dimenticare che la complessa vicenda dello smembramento della Jugoslavia generò una vera e propria guerra che durò anni e che non si è mai completamente risolta; e comunque è stata gestita col coinvolgimento delle Nazioni Unite.
- Altrettanto irrilevanti sono le motivazioni fondate sull’”accerchiamento” della NATO che non ci sarebbe mai stato se le popolazioni confinanti (e non soltanto i loro governi) non temessero le mire egemoniche della Russia, ben a ragione considerando le vicende storiche del secolo scorso quando i carri armati soffocarono brutalmente ogni tentativo di riforma. Per essere credibili nel sostenere che l’odierna Russia è cosa diversa dall’URSS bisognerebbe non ricalcarne l’autoritarismo e le mire egemoniche condensate mirabilmente nella teoria brezneviana della “sovranità limitata” dei paesi confinanti.
- Dopo l’annessione della Crimea (russofona) con gli accordi di Minsk la Russia si era impegnata a rispettare la sovranità dell’Ucraina, in cambio di un’autonomia speciale alle regioni russofone del Donbass che, per la verità, non è mai stata realizzata, anche perché in esse era subito scoppiata una guerra civile sostenuta dai russi.
- Putin ha ragione quando lamenta che gli equilibri in Europa dopo la fine della guerra fredda si sono modificati a favore degli occidentali; dimentica però di dire che tali cambiamenti sono stati condivisi e sollecitati dalle popolazioni dei paesi ex-satelliti e che, venuta meno la giustificazione ideologica staliniana, la sicurezza della Russia è largamente garantita dal suo “status” di potenza nucleare e da un apparato militare perfettamente in grado di impedire eventuali attacchi alla sua indipendenza, da qualunque parte provengano.
- Ciò di cui non parlano i sedicenti liberali in cerca di giustificazioni per l’azione russa – quasi si trattasse di questione secondaria – è la volontà delle popolazioni coinvolte in questo conflitto. Quanto contano le intenzioni e i propositi degli abitanti dei paesi confinanti, chiamati in realtà a scegliere non tanto tra gruppi etnici differenti ma tra modelli politici e sociali tra loro incompatibili quali sono oggi quello europeo occidentale e il sistema politico instaurato a Mosca? La sicurezza che chiede Putin riguarda la Russia o non piuttosto il suo regime autocratico e repressivo ?
- Oggi – piaccia o no a Putin – l’Europa liberal-democratica arriva fino al confine russo. E’ un diritto inalienabile degli ucraini decidere se farne parte, come a suo tempo hanno fatto liberamente lituani, lettoni, estoni e polacchi. Il timore di Putin probabilmente non è legato alla sicurezza militare (dove la sua superiorità sul campo è schiacciante) ma alle possibili contaminazioni che potrebbero minare il suo regime come avvenne quando si dissolse l’Unione Sovietica.
- La Russia deve fare oggi le scelte che non fece in passato. Se consolidare un modello di democrazia plebiscitaria guidata da un autocrate, secondo una tradizione collettivista di matrice orientale che tiene poco conto dei diritti individuali (a cominciare da quello di manifestare il proprio dissenso) oppure tornare a imboccare la strada della costruzione di uno stato di diritto compatibile con quello che caratterizza le democrazie liberali occidentali. La scelta autocratica avvicinerà la Russia alla Cina pseudo-comunista, l’altro percorso la riporterebbe in Europa con la quale diverrebbe possibile realizzare forme di cooperazione anche intense e risolvere in modo pacifico ogni conflittualità con i paesi adiacenti.
Infine due ultime considerazioni:
- i rapporti tra Europa e Russia sono sempre stati caratterizzati dalla consapevolezza della loro inevitabile interdipendenza; ma mentre la Russia ha bisogno dell’Europa per modernizzare le sue strutture economiche e sociali, non è vero il contrario. L’Europa ha bisogno della Russia soltanto per le risorse energetiche di cui dispone e tale dipendenza potrà essere sostituita da fonti alternative in un periodo relativamente breve, avendo gli stati europei risorse e tecnologie in grado di farlo. Gli esiti della seconda guerra mondiale hanno favorito la creazione di un’area atlantica euro-americana (con appendici importanti nel Pacifico) molto più omogenea nelle strutture economiche e sociali e nelle relazioni culturali di quanto non sia l’unità geografica dell’Europa “fino agli Urali” come un’ importante corrente di pensiero avrebbe desiderato (da Pietro il Grande a De Gaulle). Si tratta di una realtà irreversibile, soprattutto per noi liberali. Stalin (assai più di Lenin) aveva concepito il comunismo sovietico come un sistema chiuso e autoreferenziale da salvaguardare da qualsiasi contaminazione liberale, militarmente in grado di difendersi da qualsiasi attacco esterno. Dopo la breve parentesi di Krusciov (il quale invece immaginava una capacità competitiva del sistema sovietico in termini di sviluppo economico e sociale) l’URSS è tornata a chiudersi come in una fortezza assediata senza riuscire, malgrado il suo potenziale di risorse naturali, a costituire una reale alternativa al modello delle democrazie occidentali, fino a implodere anche simbolicamente col crollo del muro di Berlino. Il dilemma della Russia post-sovietica consiste appunto se tornare alla concezione staliniana della “fortezza assediata”, oppure aprire un dialogo con l’Occidente. Il quadro geo-politico però non è più quello in cui operava l’Unione Sovietica: oggi bisogna fare i conti con la Cina, il cui regime totalitario, diversamente da quello russo, è stato capace di inventare un modello economico espansivo in grado di contrastare il sistema di contenimento liberal-democratico che – analogamente a quanto fu fatto in Europa – gli Stati Uniti avevano messo in piedi in Oriente per arginare il comunismo cinese. Non c’è spazio per un terzo incomodo: il futuro della Russia si gioca su questa opzione, o con le democrazie europee (trovando un accomodamento con gli Stati Uniti) oppure con la Cina;
- i rapporti economici tra Italia e Russia sono sempre stati buoni anche durante la guerra fredda. Ma essi non possono riguardare soltanto valutazioni di convenienza economica, anche se la dipendenza energetica rende assai fragile la nostra posizione contrattuale; tolto l’approvvigionamento di gas il nostro interscambio commerciale è piuttosto modesto comparato a quello di altri paesi europei. La teoria business is business comporta necessariamente il mantenimento di relazioni commerciali con paesi autoritari e illiberali (come per esempio l’Egitto, la Cina, l’Iran, l’Arabia ecc.); ma la Russia affaccia in Europa e i problemi di sicurezza riguardano chi è militarmente debole (come noi) non certo una potenza nucleare come quella che Putin ha ereditato dall’Unione Sovietica.
Qualcuno ha proposto: Biden voli a Mosca, si sieda al lungo tavolo che Putin riserva agli ospiti che non vogliono sottoporsi a tamponi e gli proponga un trattato di non aggressione e la creazione di una fascia di sicurezza con i paesi confinanti (che comprenda però anche i territori russi adiacenti) con reciproci controlli. Sarebbe ragionevole se il problema fosse davvero quello della sicurezza russa, ma è davvero così? O piuttosto la vera intenzione di Putin è di ricostruire la “cortina di ferro”, ideologica prima che militare, con o senza il consenso delle popolazioni interessate?
Franco Chiarenza
27 febbraio 2022